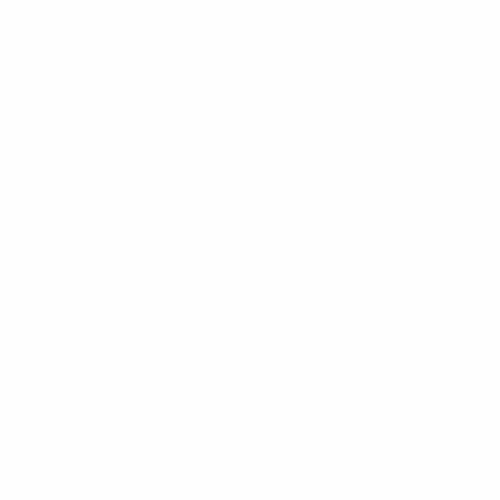After work, il docufilm diretto da Erik Gandini fa un’indagine globale sul rapporto tra esseri umani e lavoro, che ci spinge a riflettere su quanto la nostra identità sia ancora legata alla produttività.
Attraverso testimonianze da Stati Uniti, Corea del Sud, Kuwait e Italia, il film ci accompagna in un viaggio che mette a confronto visioni culturali molto diverse e ci interroga sul futuro del lavoro, dell’automazione, e del senso del tempo libero.
Lavoro: scelta o dovere?
Una delle chiavi di lettura centrali del film è la differenza tra l’approccio occidentale e orientale al lavoro.
Occidente: il lavoro come realizzazione personale
Nei Paesi occidentali, il lavoro è spesso vissuto come una scelta individuale, uno strumento per raggiungere la propria indipendenza, esprimere sé stessi e costruire un’identità. Ma questa visione ha anche un lato oscuro: la pressione costante alla performance, il burnout, lo stress, l’ossessione per il successo.
Nel film, un consulente aziendale americano spiega che per molte aziende, ciò che conta non è tanto la formazione o le competenze, quanto l’etica del lavoro: presentarsi puntuali, essere disponibili, non opporsi. Una visione che valorizza la produttività più della persona.
Eppure, secondo Gallup, solo il 15% delle persone che lavorano si sentono davvero coinvolte nel proprio lavoro. Il resto si limita a “fare il minimo” oppure, peggio, si sente attivamente frustrato.
Oriente: il lavoro come dovere sociale
In molte culture orientali, come in Corea del Sud o in Giappone, il lavoro è considerato un dovere morale. Non è solo una questione individuale, ma un atto di rispetto verso la famiglia e la società.
Essere senza lavoro, soprattutto per le generazioni più anziane, significa perdere valore umano. Non a caso in Corea chi lavora è definito una “persona modello”. Ma questo senso del dovere porta con sé effetti collaterali gravissimi, come il fenomeno del karoshi, la morte per eccesso di lavoro.
Nel film, una scena toccante mostra una figlia che racconta l’assenza emotiva del padre, sempre davanti a uno schermo, incapace di essere presente nella vita familiare.
Etica lavorativa: individualismo vs collettivismo
Un’altra differenza centrale tra le culture è il modo in cui viene vissuta l’etica del lavoro.
In Occidente, il lavoro è spesso legato al merito personale. Successo e fallimento dipendono (almeno in teoria) dall’impegno individuale. Questo modello favorisce la libertà e l’innovazione, ma genera anche insicurezza e competizione costante.
In Oriente, l’etica è più collettivista. Il successo è visto come il frutto di uno sforzo comune. La lealtà all’azienda e il rispetto delle gerarchie sono valori fondamentali, ma rischiano di soffocare la creatività e rendere difficile ogni forma di cambiamento.
Automazione: un futuro senza lavoro?
Con l’avanzare di automi e software sempre più capaci di sostituire l’essere umano in molte mansioni, si apre un dibattito messo in luce dalle affermazioni di Musk e Harari.
Musk, in uno spezzone del film, sostiene che l’introduzione di un reddito di base universale possa garantire la sussistenza alle persone senza lavoro. Per lui, la tecnologia può liberare gli individui dalle attività più faticose, offrendo loro la possibilità di dedicarsi a passioni e creatività.
Harari, con la sua affermazione che «nel XXI secolo la battaglia sarà contro l’irrilevanza, perché è peggio essere irrilevanti che sfruttati», mette in guardia sul rischio che milioni di persone possono diventare “superflue”. Secondo lui, la perdita del lavoro non rappresenta solo una questione economica, ma può innescare una profonda crisi d’identità e di senso, dal momento che per secoli il lavoro è stato il principale motore dell’autostima e del valore personale. La sua tesi centrale è che, con il progresso dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, molte professioni — soprattutto quelle che comportano compiti ripetitivi o l’elaborazione di dati — saranno sostituite dalle macchine. Questo porterà all’emergere di una nuova classe di individui “inutili”, le cui competenze non saranno più richieste in un’economia dominata da algoritmi e robot. Ma il concetto di “inutilità” va oltre la semplice perdita di un lavoro: coinvolge anche l’identità personale, perché molte persone traggono senso e autostima proprio dal proprio ruolo professionale. Se il lavoro cessa di essere una parte significativa della vita per la maggioranza, ci si deve allora chiedere quale sarà il destino dell’identità e dell’autostima umana. La soluzione proposta da Musk sembrerebbe essere un reddito di base universale, un assegno che assicurerebbe a ogni individuo un reddito minimo indipendentemente dall’attività lavorativa.
Il paradosso del Kuwait
Il caso del Kuwait, raccontato in After Work, rappresenta un esempio paradossale per riflettere sul concetto di reddito di cittadinanza universale. Nel paese, molti cittadini occupano posti nella pubblica amministrazione senza avere reali compiti da svolgere: si presentano al lavoro, timbrano e poi passano l’orario di lavoro a leggere o vedere film.
Nonostante la loro scarsissima produttività, ricevono uno stipendio fisso garantito dallo Stato, frutto di un sistema fondato sulla rendita petrolifera.
Questa condizione può ricordare, almeno superficialmente, l’idea di un reddito di base universale. Tuttavia, ciò che emerge è tutt’altro che una condizione di libertà o di emancipazione. Le persone, nel film, raccontano un senso di vuoto e inutilità. E il tempo, privo di un significato concreto, diviene noia.
Ciò che accade in Kuwait fa riflettere sul fatto che sganciare il reddito dal lavoro non è automaticamente sinonimo di libertà. Serve anche una ridefinizione culturale del tempo libero, dell’utilità sociale e del significato dell’agire umano.
Giovani NEET e disoccupazione
Con il termine NEET si fa riferimento a persone, solitamente giovani (nella fascia 15-34 anni), che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione professionale. Essi rappresentano una delle sfide più urgenti e complesse per il sistema socio-economico del Paese. La loro condizione riflette criticità profonde nella transizione tra scuola e lavoro, una crescente sfiducia nelle istituzioni e un progressivo impoverimento delle competenze. Le conseguenze sono gravi sia sul piano individuale sia su quello collettivo, con perdita di capitale umano e aumento dei costi sociali.
La perdita della speranza
Rimanere per un lungo periodo nella condizione di NEET non è solo un passaggio temporaneo, ma un rischio concreto di cristallizzazione dell’inattività. Il tempo prolungato fuori da contesti educativi o occupazionali incide profondamente sulla motivazione individuale, mina la fiducia in sé stessi e riduce progressivamente la capacità di immaginare un futuro attivo e autonomo. Questo stato, se non affrontato con tempestività, può evolvere in una forma cronica di esclusione sociale. Inoltre, è stato dimostrato che i NEET disoccupati da oltre un anno mostrano i livelli più bassi di soddisfazione di vita, inferiori anche rispetto ad altri NEET e nettamente distanti da coetanei studenti o lavoratori.
La necessità di agire
Ridurre il fenomeno dei NEET a una semplice questione occupazionale è una semplificazione fuorviante: ciò che è in gioco è anche la costruzione dell’identità, il senso di appartenenza e la capacità di immaginare un futuro. Come suggerisce il docufilm After work, non si tratta solo di reinserire i giovani nel mercato del lavoro, ma di ripensare più radicalmente il valore e il significato che attribuiamo al lavoro stesso. Il documentario mostra come i giovani che si trovano in condizione di disoccupazione non siano semplicemente “persi”, ma in alcuni casi perfino resistenti a un sistema che non offre reali prospettive di autorealizzazione.
La paura del tempo libero
Una delle riflessioni più potenti trattate all’interno di After work riguarda la trasformazione radicale del nostro rapporto con il tempo libero. In esso viene affermato che il 55% degli americani ha rinunciato volontariamente ai propri giorni di ferie per continuare a lavorare. Non per bisogno economico, ma per paura di sentirsi inutili: il tempo libero si è trasformato in uno spazio vuoto, quasi minaccioso, che genera ansia, senso di colpa e smarrimento.
Non è un caso che in paesi come la Corea del Sud molte persone lavorino dalle 7 del mattino fino alle 11 di sera, sei giorni su sette. Quando la vita si restringe al solo ambito lavorativo, ciò che viene meno non è solo il tempo, ma anche la possibilità di coltivare relazioni e passioni.
Invece, un esempio significativo che viene presentato all’interno del docufilm è quello di un italiano benestante che, pur potendo vivere senza lavorare, sceglie di dedicarsi con passione al giardinaggio professionale. Questa scelta rafforza l’idea che non sia il lavoro in sé a essere il problema, ma la perdita dell’autonomia nella scelta di cosa fare e come farlo.
Se avessi uno stipendio senza lavorare, cosa faresti della tua vita?
Questa è la domanda conclusiva che viene posta agli intervistati in “Afterwork”, essa viene posta come provocazione per scuotere le fondamenta di una cultura che da secoli lega il valore della persona al lavoro e alla produttività. In un mondo in cui l’automazione sta rapidamente cambiando le regole del gioco, After work ci spinge a immaginare un futuro diverso, dove non siamo più definiti da quanto produciamo, ma da chi siamo davvero.
Il film ci invita a superare il vecchio mito del lavoro come unica fonte di identità e riconoscimento, aprendo la porta a una riflessione profonda sul significato autentico della libertà, sul tempo vissuto con consapevolezza e sul valore umano che esiste al di là dell’economia. Dunque, la vera sfida è quella di reinventare il senso della nostra vita, costruendo un mondo in cui il lavoro diventi solo una parte della nostra esistenza.
Le autrici

Beatrice D’Achilli
Junior HR
Discover more on Linkedin

Ilaria Vignarelli
Junior HR
Discover more on Linkedin